|
|
|
|
|
|
Indietro
|
|
Diritto del padre lavoratore ad usufruire dei riposi giornalieri “per allattamento”nel caso in cui la madre sia casalinga
|
|
a cura di Gianni Bovio funzionario pubblico
|
| |
L’Inps, con la circolare n. 118 del 25 novembre 2009, adeguandosi all’indirizzo interpretativo assunto in proposito dal Consiglio di Stato, ha riconosciuto il diritto del padre lavoratore dipendente ai riposi giornalieri per allattamento anche nell’ipotesi in cui la madre sia casalinga. I riposi in questione sono quelli previsti dall’art. 39 del d.lgs. n.. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela della maternità e della paternità) e consistono in 2 periodi giornalieri di un’ora ciascuno, o di uno solo nel caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore, di cui la lavoratrice madre ha diritto di fruire dal termine dell’astensione obbligatoria per maternità e fino al compimento del primo anno di vita del bambino, o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Il successivo art. 40 riconosce anche al padre lavoratore la fruizione di detti riposi al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il bambino sia affidato al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Per le ipotesi di cui ai precedenti punti a), b) e d), non sono mai sorti particolari problemi applicativi, in ragione del loro ricorrere in
presenza di casi in cui la richiesta di fruizione dei permessi da parte del padre è alternativa alla madre, data l’oggettiva impossibilità
di attendere ai relativi compiti da parte di quest’ultima. Diversamente, l’ipotesi di cui alla lettera c) ha avuto un’interpretazione, da parte dell’istituto previdenziale, che è andata progressivamente modificandosi in senso più favorevole al padre lavoratore, sulla scorta, soprattutto, di sentenze ed orientamenti amministrativi dichiaratamente volti a privilegiare il ruolo di cura della prole proprio di entrambi i genitori. In proposito, infatti, l’Inps aveva in un primo tempo stabilito, con la circolare n. 95-bis del 6 settembre 2006, che per madre non lavoratrice dipendente dovesse intendersi esclusivamente la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, libera professionista, parasubordinata, coltivatrice diretta, imprenditrice agricola, colona, mezzadra), escludendo l’ipotesi di madre casalinga.
Conseguentemente, nei casi in cui la madre risultava casalinga, al padre non veniva riconosciuta la possibilità di usufruire dei riposi
giornalieri in questione.
Tale interpretazione non è però stata condivisa dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, ha equiparato la madre che svolge attività di casalinga alla madre lavoratrice autonoma, ai fini del riconoscimento al padre del diritto ai riposi giornalieri per allattamento.
Pertanto, l’Inps ha dovuto mutare il proprio orientamento prevedendo, con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei detti riposi in tutti quei casi – opportunamente documentati – di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di occuparsi della cura del neonato (ad esempio perché impegnata in accertamenti sanitari, o per cure mediche, o per la partecipazione a pubblici concorsi e ipotesi similari).
Tuttavia, il nuovo indirizzo assunto dall’istituto di previdenza non è parso del tutto rispondente ai principi che il Consiglio di Stato
aveva posto a fondamento della citata sentenza, tanto che il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, con apposita nota del 16 novembre 2009, ha precisato che, nel caso di madre casalinga, il diritto del padre ad usufruire dei riposi giornalieri deve essere riconosciuto senza eccezioni. Con la circolare n. 118 del 25 novembre 2009 l’Inps, conformandosi a tali indicazioni, ha quindi stabilito che nel caso di madre casalinga, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di 2 ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, senza dover dare alcuna dimostrazione dell’impossibilità della madre ad accudire il bambino. Inoltre, il padre lavoratore dipendente che, vigente il precedente orientamento, avesse fruito di ferie o permessi orari entro l’anno di vita del figlio o di ingresso in famiglia del minore, potrà, entro un anno dall’ultimo giorno di assenza, presentare al proprio datore di lavoro e all’istituto previdenziale apposita domanda, intesa a convertire tali assenze in riposi giornalieri per allattamento, la cui relativa indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente portata a conguaglio con i contributi mensili dovuti.
Questa è l’analisi dell’evoluzione che ha subito la fattispecie, condotta nei termini più descrittivi ed oggettivi possibili.
Passando, ora, ad indagare le ragioni che hanno indotto la giustizia amministrativa ad operare una così invasiva incursione all’interno
della prassi applicativa che si era, fino alla richiamata sentenza del 9 settembre 2008, consolidata, và innanzitutto evidenziato come
l’applicazione della norma in esame inizialmente sostenuta dall’Inps non discendeva certo da una sua interpretazione letterale, quanto
da una organica lettura che l’istituto di previdenza, verosimilmente, faceva dell’intero articolato normativo. In altri termini, la spettanza al padre dei permessi giornalieri per allattamento era considerata in funzione esclusivamente di supplenza della madre, principale titolare del diritto, e, in effetti, le ipotesi elencate sub lett. a, b, e d dell’art. 40, d.lgs. n. 151/2001, possono correttamente essere intese quale concretizzazione di tale principio.
Conseguentemente, l’Inps, allorquando veniva chiamato a prendere in esame domande del padre lavoratore intese alla fruizione di tali
permessi ai sensi della lett. c del citato art. 40 (nelle ipotesi, cioè, in cui la madre non sia lavoratrice dipendente), richiedeva, ai fini
della loro concessione, la dimostrazione del fatto che la madre fosse impegnata in un lavoro autonomo, ritenendo che solo in tal caso il relativo diritto potesse traslare in capo al padre lavoratore dipendente. Non era, però, dello stesso orientamento il Consiglio di Stato che, con la citata decisione del 9 settembre 2008, sulla scorta della condizione di lavoratrice che è innegabilmente propria anche della
madre casalinga, ne faceva derivare la sostanziale equiparazione alla madre lavoratrice dipendente ed alla madre lavoratrice
autonoma, con conseguente possibilità per il padre di beneficiare dei permessi per allattamento, senza null’altro dover dimostrare che la condizione di casalinga dell’altro genitore.
Per giungere a detta conclusione i giudici amministrativi hanno ritenuto di seguire un percorso interpretativo articolato che, per alcuni suoi riflessi, sembra lasciare spazio a qualche perplessità. Le regole per una corretta indagine ermeneutica poste dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, prevedono infatti, com’è noto, che quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non debba
ricorrere ad alcuna regola interpretativa sussidiaria. Ciò premesso, la locuzione «nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente», cui consegue la spettanza al padre dei permessi in parola, potrebbe – a parere di chi scrive – essere letteralmente intesa come riferita a tutti i casi in cui la madre non sia parte di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, abbia cioè un’occupazione autonoma, ovvero sia casalinga, ed anche nel caso in cui, per ipotesi, non svolga alcun tipo di attività, né professionale né per la cura della propria casa.
Evidentemente e condivisibilmente, però, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la finalità della norma in esame sia da individuare nella
facoltà, per il padre lavoratore, di utilizzare i permessi giornalieri c.d. per allattamento in alternativa alla madre, qualora quest’ultima
sia impegnata in attività lavorativa di qualsivoglia natura ed ha, pertanto, stabilito che la locuzione in parola debba estensivamente e più appropriatamente intendersi come riferita ai casi in cui la madre sia lavoratrice non dipendente, equiparando, poi, alla madre
lavoratrice non dipendente la madre impegnata esclusivamente quale casalinga. Senonchè, ad una corretta opzione interpretativa,
l’autorevole organo di giustizia amministrativa fa conseguire, in nome della concretizzazione del principio di tutela della maternità e
della famiglia, un’equiparazione fra condizioni oggettivamente diverse che, se analizzata in tutti i suoi possibili riflessi operativi,
appare foriera di un difficilmente giustificabile aspetto di discriminazione. È, infatti, comunemente condivisa la considerazione in base alla quale, nella quasi totalità dei casi, la donna impegnata in qualsivoglia attività lavorativa extrafamiliare, sia a carattere autonomo che dipendente, si trovi a dover coniugare detta attività con quella, ulteriore, di cura dell’abitazione e della prole propria della casalinga.
L’innegabilità di tale considerazione conduce a ragionevolmente dubitare che il Consiglio di Stato abbia, con l’equiparazione della
madre casalinga alla madre occupata anche in altre attività al di fuori del contesto familiare, realizzato un equo componimento di tutti gli interessi in gioco. Più in concreto, quali argomenti potranno essere validamente opposti all’eventuale doglianza di una madre
titolare di un rapporto di lavoro di natura subordinata che, utilizzando i c.d. permessi giornalieri per allattamento, ne vede pregiudicata la fruizione da parte del padre lavoratore dipendente, mentre la possibilità di fruizione da parte di quest’ultimo risulta sempre consentita nei casi in cui la madre è impegnata esclusivamente in mansioni di casalinga?
a cura di Gianni Bovio Funzionario della Direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola
*Le considerazioni contenute nell'articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.
|
|
|
|
|
|

STAMPA QUESTA PAGINA
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
|
 |
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
|
 |
|
|
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
|
 |
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
|
 |
|
|
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
|
 |
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
|
 |
|
|
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
|
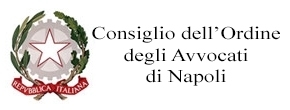 |
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
|
|
|
|
|
|
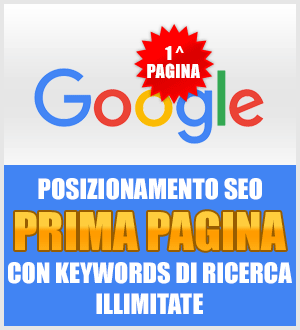
|
|
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
|
 |
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
|
 |
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
|
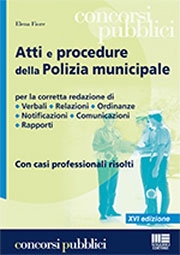 |
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
|
 |
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
|
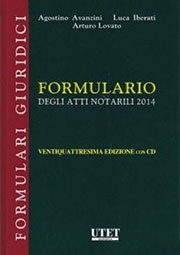 |
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
|
 |
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
|
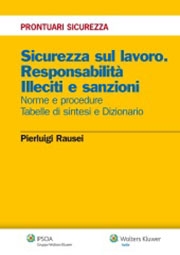 |
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|